|
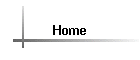
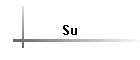
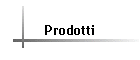

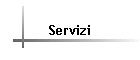
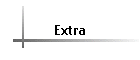
| |
|
|
 |
 |
| Quando è
nata l'esigenza di un "ombrello" per tutelarsi dagli imprevisti
della vita? E a chi è venuto per primo in mente di proporre
l’assicurazione? |
|
|
La
storia – o meglio l’origine - delle assicurazioni in Italia è molto
antica: i primi documenti risalgono infatti al 1300 e, data la
lontananza temporale che ci separa da essi, risulta difficile
stabilire quale sia la prima polizza comparsa nel nostro Paese. Al di
là delle diverse scuole di pensiero e i differenti metodi di indagine,
un fatto è certo: è nell’area ligure e toscana che si hanno i
primi esempi di contratti che possono essere paragonati alle moderne
polizze. È nell’ambiente economico del XIV secolo che si
afferma un’idea nuova: l’assunzione del rischio altrui come
operazione speculativa autonoma. Nasce così l’assicurazione “a
premio”.
 Genova, 1368 Genova, 1368
Abbiamo la segnalazione di una famiglia che può essere considerata
l’antesignana delle compagnie di assicurazione: la Luxardo di Genova.
Uno dei suoi componenti, Federico, nel 1350 si fa notare come già
attivo nei traffici commerciali e nell’attività di compravendita sulla
piazza ligure. Esiste addirittura una polizza che vede in veste di
assicuratore Raffaele Luxardo, il quale assicura la nave di Niccolò
Becchignone per la somma di 425 perperi d’oro, da rendere a Peyra, una
volta che sia arrivata a destinazione. Il documento, redatto dal
notaio Teramo Maggiolo, risale al 21 febbraio 1368.
Ma le ricerche degli storici proseguono senza fermarsi mai,
alimentando quasi una gara fra Genova, Firenze e Pisa, per stabilire
chi possa essere il primo “inventore” di una polizza quale la
intendiamo oggi.
 Pisa, 1379 Pisa, 1379
Lo storico Federigo Melis cita un documento pisano del 1379 come "la
più antica polizza finora reperita".
 Genova, 1347 Genova, 1347
Enrico Bensa, professore di Diritto commerciale, industriale e
marittimo nella sua opera “Il contratto di assicurazioni nel Medio
Evo”, pubblicata a Genova nel 1884 si sofferma sull’atto
notarile assicurativo stipulato in Genova il 23 ottobre 1347,
proponendolo come primo contratto assicurativo di cui si abbia
conoscenza.
 Genova, 1343 Genova, 1343
Ancora Melis, nelle “Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia”
pubblicate nel 1975 a documentare di essersi buttato nelle migliaia di
rogiti notarili di quell’epoca conservati nell’Archivio genovese per
portare alla luce "il più remoto contratto di assicurazione
certa". E’ un documento datato 20 febbraio 1343,
redatto dal notaio Casanova, e nel quale il genovese Tommaso Grillo
(che opera in nome di tale Avveduto Guglielmi, palermitano) si fa
assicurare f. 680 – sulla galea Santa Caterina – fingendo di aver
ceduto a prestito tale somma al cittadino Amigneto Pinello (che
agisce, quindi, da assicuratore); somma che gli sarà rimborsata nel
caso di mancato arrivo della nave sull’itinerario Porto Pisano-Sicilia.
La copertura riguarda "ballas decem pannorum", dieci balle di panni.
Le ricerche del Melis hanno portato alla luce sempre nel 1343, altri
quattro contratti che presentano l’assicurazione sotto le finte vesti
di un prestito. Sono note come una forma mascherata di polizza,
tipicamente detta “genovese”. Si finge che l’indennizzo
promesso da chi svolge il ruolo di assicuratore sia l’importo di un
mutuo concesso gratuitamente all’assicurato. Questi – dichiarandosi
debitore – promette di restituire la somma al primo caso di mancato
arrivo della nave, o della merce, entro un dato termine temporale. In
caso di buon esito del trasporto, il contratto viene considerato
nullo, come se fosse viziato da errore nella stipula.
Fu la “novità” circa l’inedita figura di un terzo (l’assicuratore) che
– per guadagno – promette di accollarsi un rischio a lui del tutto
estraneo a convincere i notai genovesi, estensori dei contratti, a
mantenere per parecchio tempo in vita la loro formula “mascherata”.
 Pisa, 1379 Pisa, 1379
In ambito toscano, a stipulare i contratti assicurativi
furono subito i “sensali di sicurtà”. Queste figure
professionali agivano in mezzo ai mercanti, con forte spirito di
intraprendenza nel mettere a punto le polizze. Per loro il problema
non si pose mai, pronti a dichiarare apertamente la sostanza del
negozio assicurativo. Sarà questa schiettezza tipicamente toscana ad
aver convinto a considerare come autentica prima polizza, quella
redatta a Pisa dal sensale Boninsegna di messer Rinuccio il 13 aprile
1379: in essa infatti si delinea in modo lampante sia la figura
dell’assicurato sia quella dell’assicuratore.
La Previdenza sociale in Europa
La concezione germanica aveva come substrato culturale la
filosofia hegeliana, secondo cui lo Stato era razionale in sé e per
sé, e l'individuo aveva oggettività e moralità solo in quanto membro
dello Stato.
La trasposizione di questa concezione sul piano della protezione
sociale, portò a sostenere come necessario l'intervento dello Stato
per tutelare i lavoratori, in modo che l'imprevidenza dei singoli
fosse corretta in funzione del superiore interesse della nazione, e
affinché le occasioni di malcontento sociale fossero ridotte al
minimo: spettava allo Stato garantire all'individuo che cessava di
lavorare il mantenimento di un tenore di vita simile a quello
posseduto durante la vita lavorativa, riconoscendo una
prestazione pensionistica commisurata alla sua retribuzione. Non fu
quindi un caso che il primo modello di protezione sociale dei
lavoratori promosso direttamente da uno Stato ebbe origine
nell'allora Confederazione Germanica (essendo poi adottato, nella
sua impostazione di base, da altri paesi europei, fra cui Francia e
Italia).
Nel 1881 il cancelliere Bismarck sollecitò il Parlamento ad
emettere leggi per introdurre l'assicurazione operaia obbligatoria
contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità e la vecchiaia:
leggi che furono emanate nel 1883 (malattia), nel 1884 (infortuni
sul lavoro) e nel 1889 (pensione di vecchiaia, d'invalidità e ai
superstiti). Contrariamente a quanto sostenuto dalla concezione
germanica, la concezione anglosassone, fondata sulla filosofia di
Locke, individuava il fondamento dell'autorità politica nella
volontà degli individui, facendo coincidere la nascita della società
civile con la presa di coscienza dei cittadini di dover essere gli
esecutori della legge: lo Stato non doveva intervenire in alcun modo
in campo economico e sociale, ma limitarsi a garantire una tutela
puramente assistenziale, uguale per tutti, e da erogare solo in
specifiche circostanze d'indigenza. Tale concezione influenzò la
nascita e lo sviluppo della protezione sociale dei lavoratori nel
Regno Unito e nei paesi nordici, dove infatti non venne istituito un
sistema di assicurazioni sociali, ma dove venne semplicemente esteso
il già esistente sistema assistenziale, introducendo il principio
del diritto soggettivo di tutti i cittadini - e quindi anche dei
lavoratori - ad accedere alle prestazioni previste. Nel Regno Unito,
ad esempio, l'importo delle prestazioni pensionistiche fu limitato
alla pura sopravvivenza e riconosciuto solo agli ultrasettantenni
privi di redditi sufficienti. Va comunque notato che alla fine del
secolo scorso, soprattutto nel Regno Unito, avevano una larghissima
diffusione i contratti di assicurazione popolare sulla vita,
proposti da compagnie private di assicurazione; quindi la maggior
parte degli operai di questi
paesi aveva già una copertura assicurativa.
La nascita della previdenza sociale in Italia.
In Italia, la nascita e lo sviluppo del sistema previdenziale
pubblico furono influenzati, come già accennato, dall'impostazione
adottata nella vicina Confederazione Germanica. Il primo
provvedimento in materia fu adottato nel 1864, quando fu istituita
per i dipendenti del nuovo Stato unitario l'assicurazione
obbligatoria per la vecchiaia: i contributi che man mano maturavano
erano posti a carico del bilancio dello Stato e l'importo della
pensione era commisurato all'ultima retribuzione. Il legislatore
italiano, poi, si preoccupò della tutela pensionistica obbligatoria
di quelle categorie di lavoratori che, pur non essendo direttamente
dipendenti dello Stato, svolgevano funzioni di preminente interesse
nazionale; in poco più di vent'anni furono istituite la Cassa
Pensioni per gli insegnanti, per i medici condotti, per i dipendenti
degli enti locali, nonché altre Casse minori. In base alle leggi
istitutive, l'equilibrio tecnico-attuariale di queste Casse si
fondava su un'articolata gestione dei versamenti in dei conti
individuali in nome dei singoli dipendenti, e la prestazione
pensionistica era funzione dei versamenti accreditati
in tali conti, maggiorati degli interessi maturati. Tuttavia, mentre
nella prima fase d'operatività delle Casse i montanti relativi a
ciascun conto individuale furono valutati come risultati contabili
ottenuti ex-post, in un secondo momento la gestione fu fondata su
un'equivalenza attuariale - a priori e per
rischi omogenei - tra contributi versati e prestazioni spettanti
(questo genere di equivalenza presiedeva, e presiede tuttora, al calcolo dei cosiddetti "premi equi" delle assicurazioni libere sulla
vita, gestite a "capitalizzazione individuale").
Come si può notare le polizze, la previdenza, le tutele,
sono concetti attinenti alla vita dell'Uomo. Tanto da creare
sistemi e coperture conformi alle ideologie ed alla storia dei
singoli popoli, come per il caso della previdenza sociale. Resta di
fondo la valorizzazione del concetto di base dell'assicurazione, il
valore della persona e del suo lavoro, e della sua tutela.
Bibliografia
E. BENSA, Il Contratto di assicurazione nel Medio Evo, Genova 1884.
Atti della Mostra bibliografica e del Convegno internazionale di studi
storici del diritto marittimo medioevale, Napoli 1934.
E. BENSA, I più antichi esemplari di polizze di carico, Milano 1925.
E. BENSA, Ancora sopra una singolare formola negli atti notarili
genovesi, 1927.
F. MELIS, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli
XIV-XVI), Roma 1975.
A. LA TORRE, L’assicurazione nella storia delle idee, Roma 1995.
G. Stefani, Le Assicurazini a Venezia: dalle origini alla fine della
Serenissima, Trieste 1956.
|
 |
|
|